
0%

Costruiamo ponti tra talento e opportunità , tra il presente e il futuro, tra generazioni che vogliono capirsi e crescere insieme.







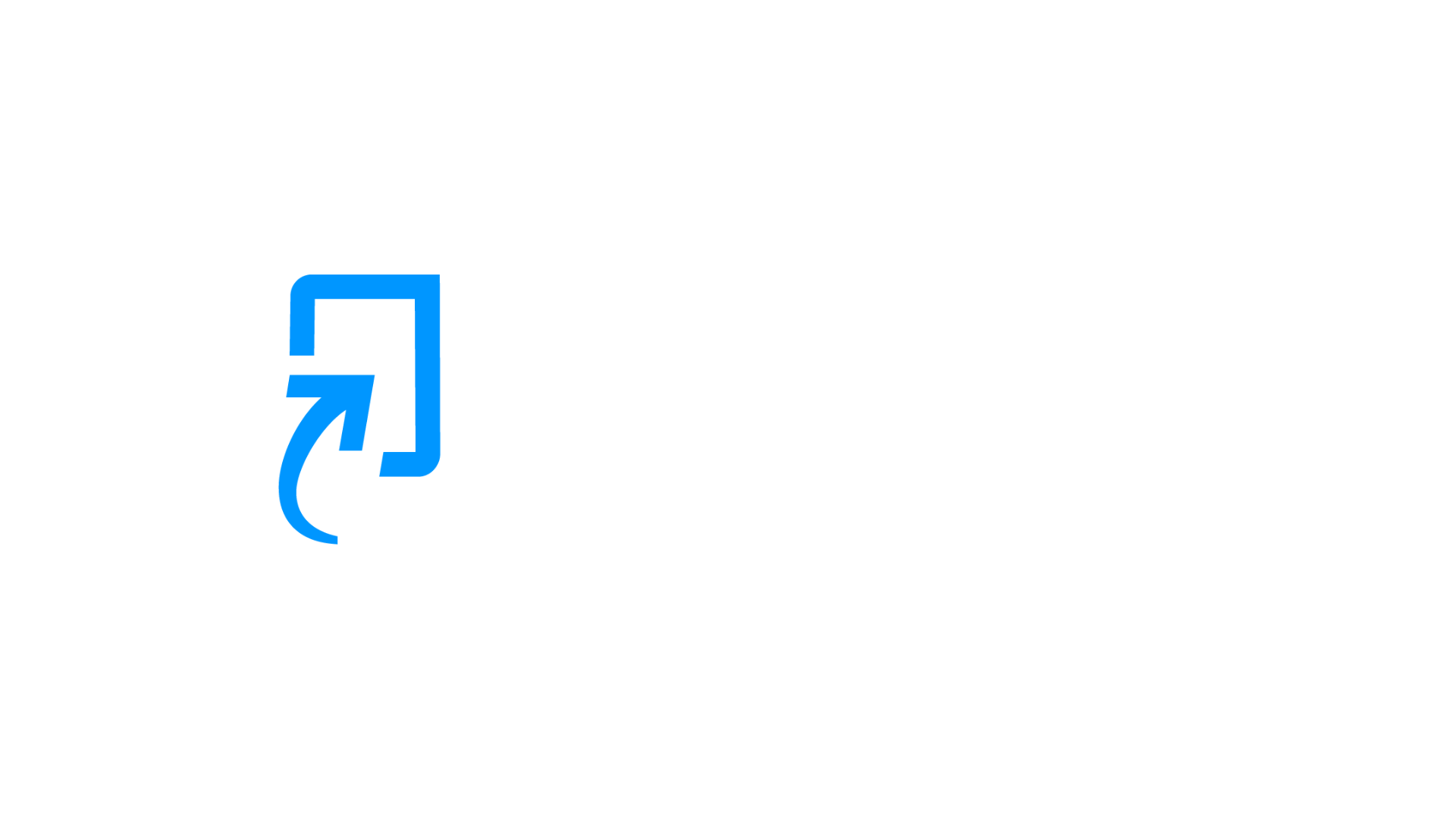
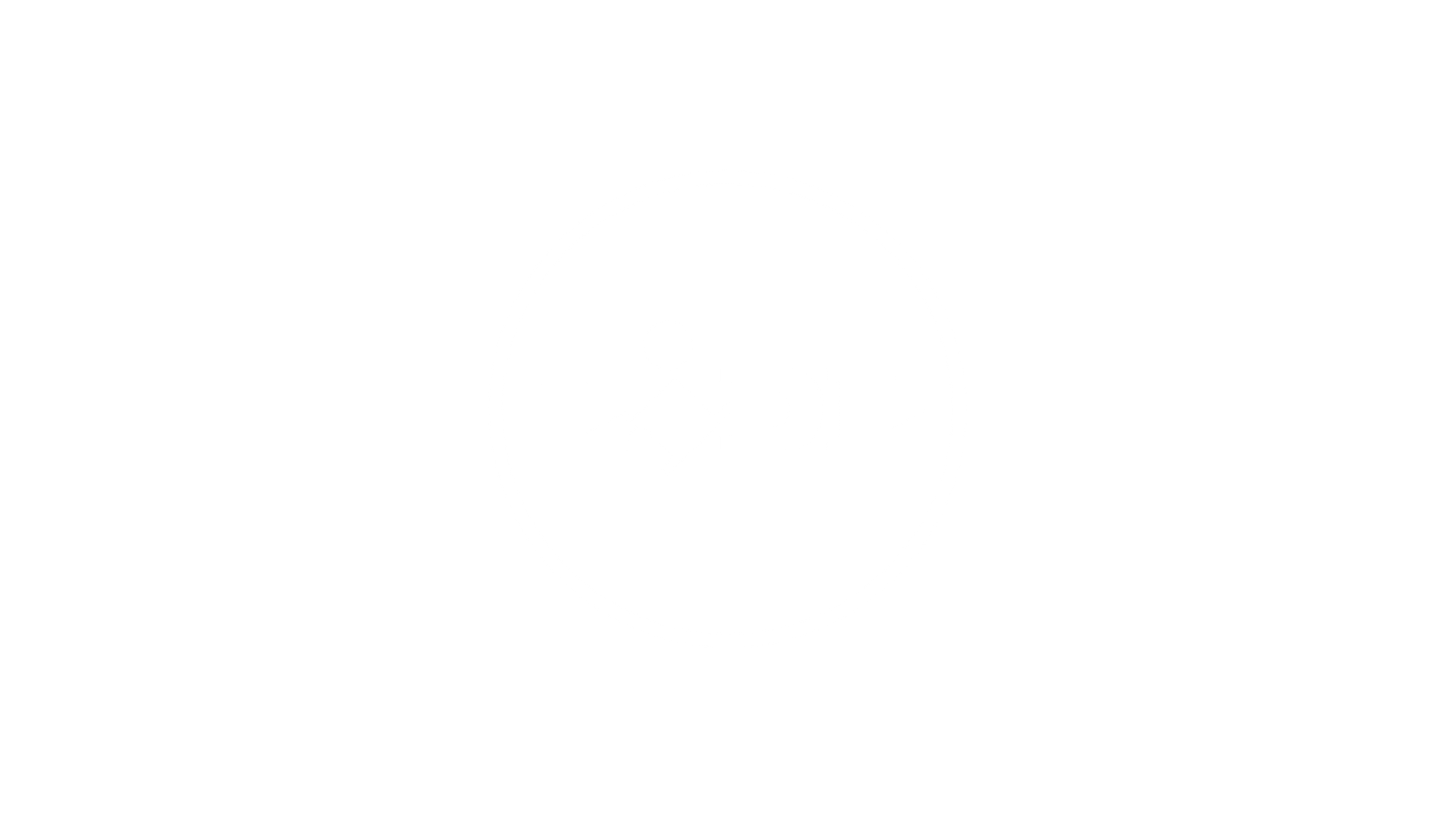
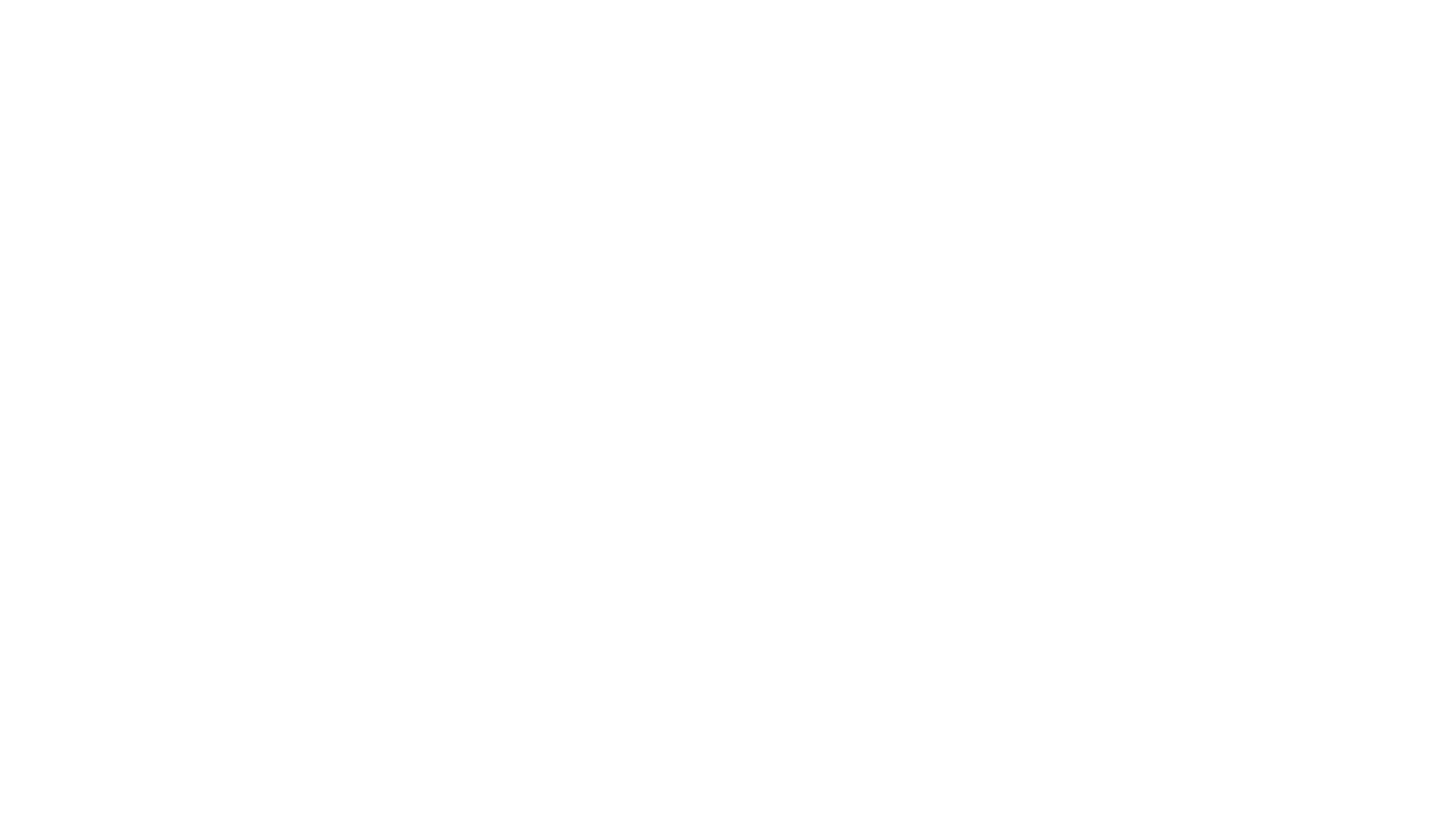
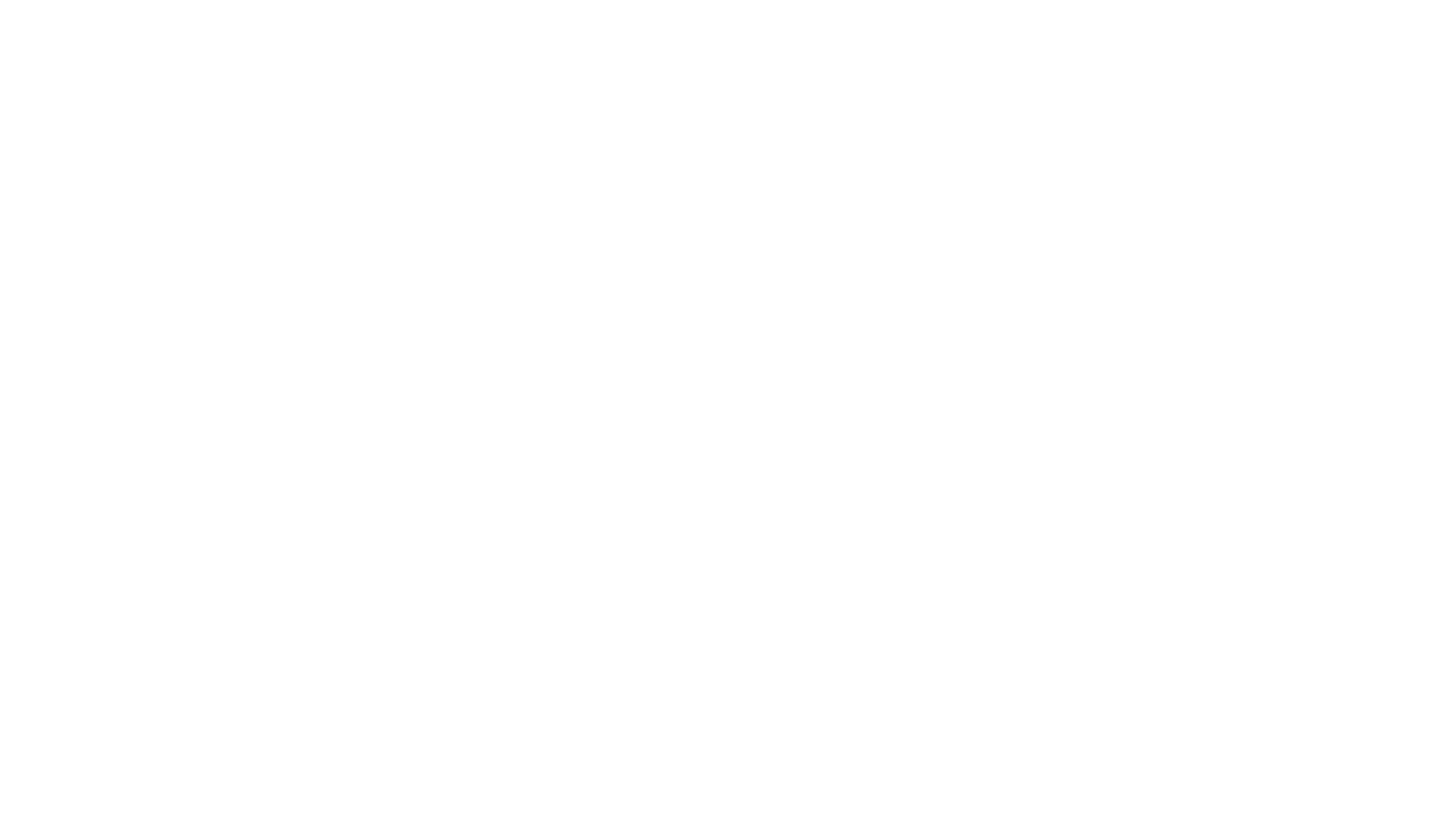
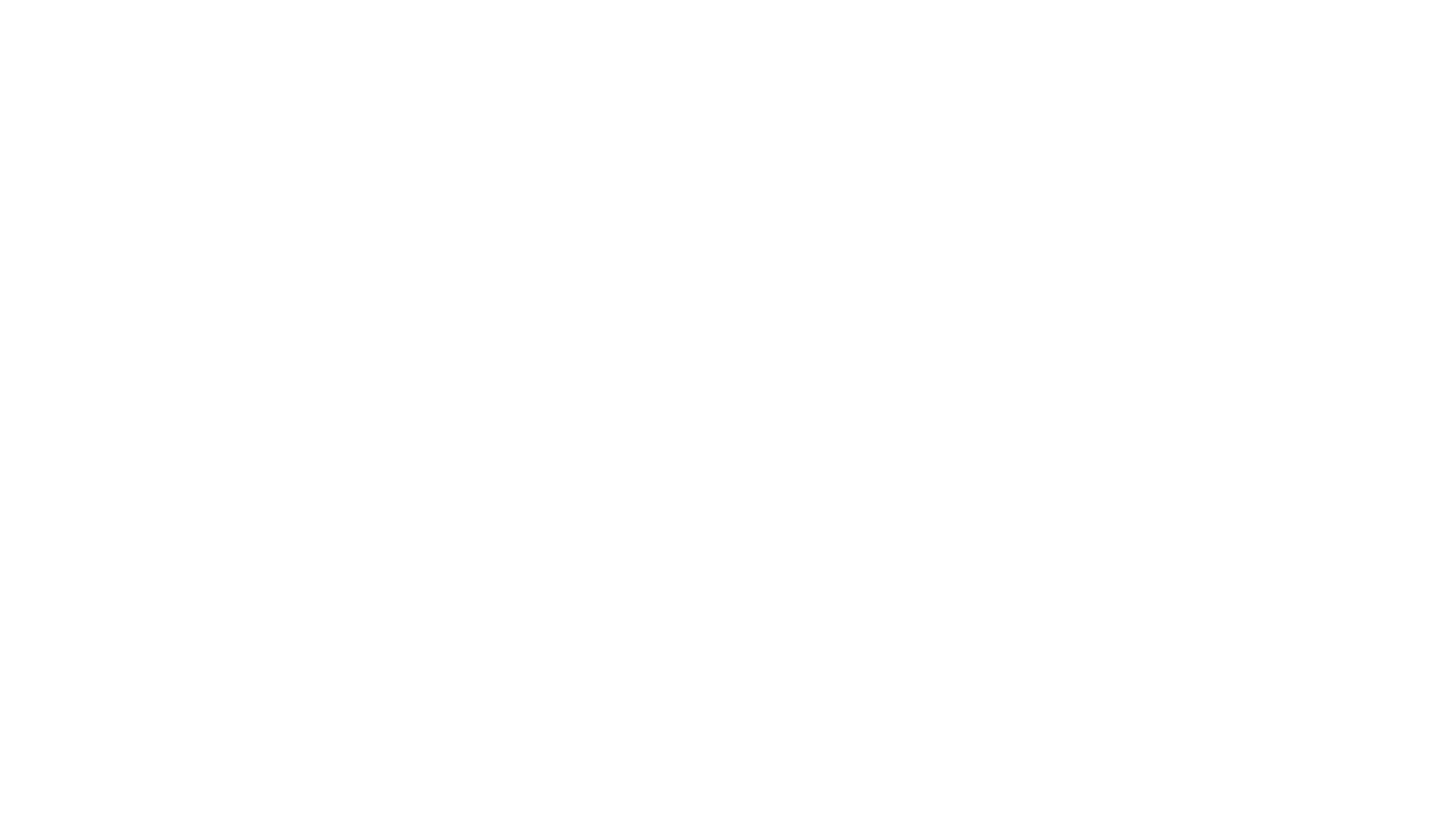


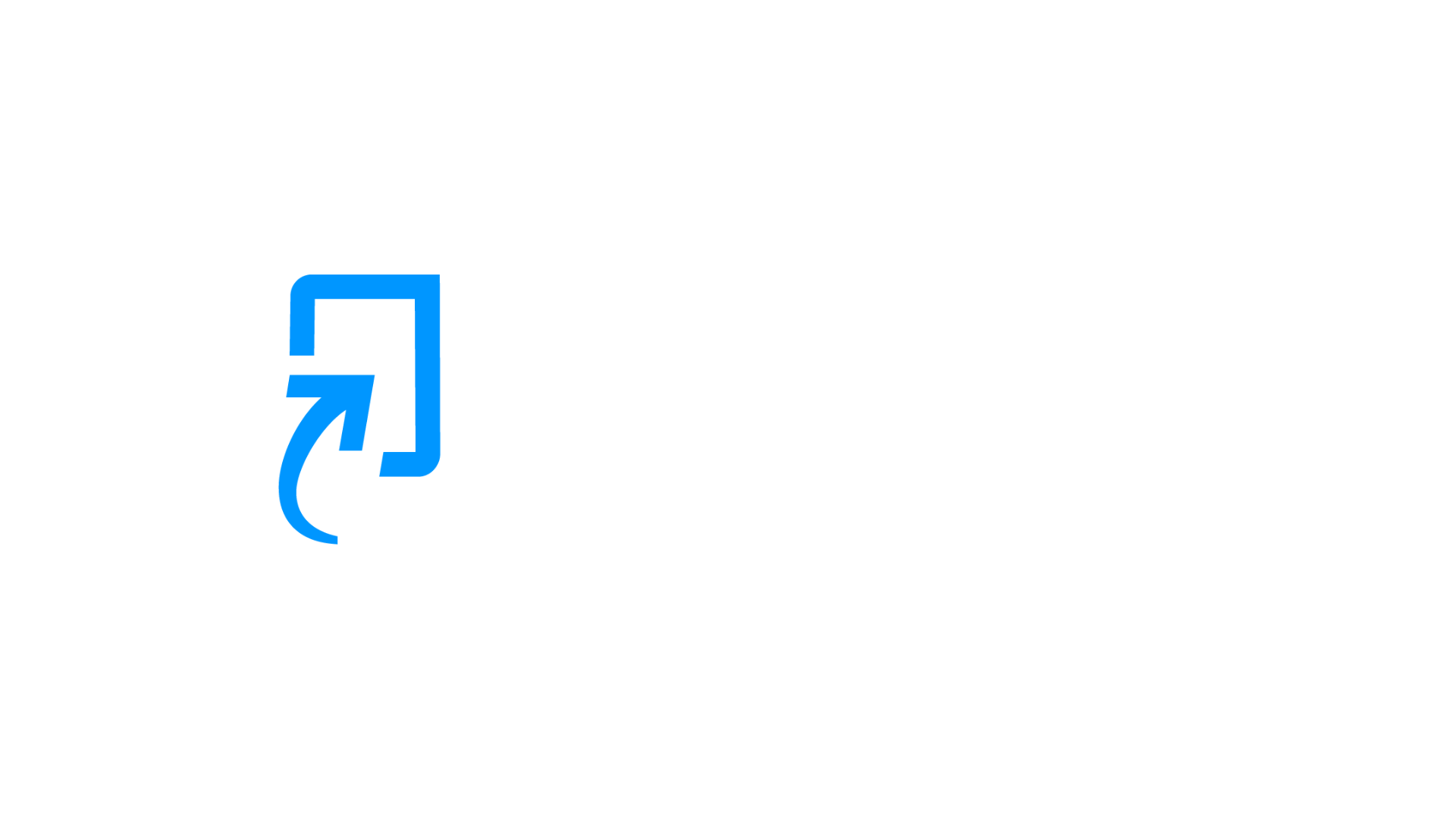
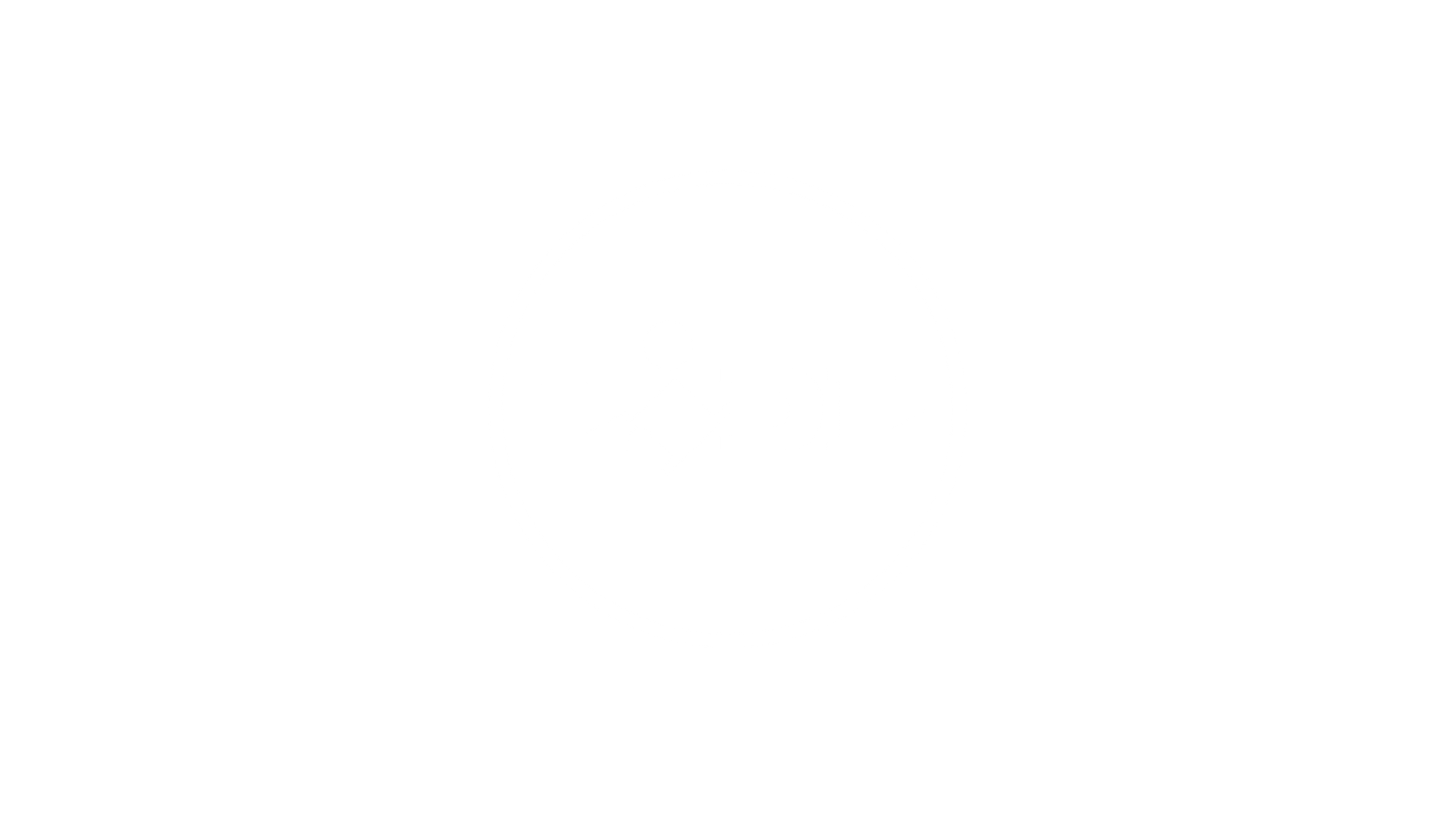
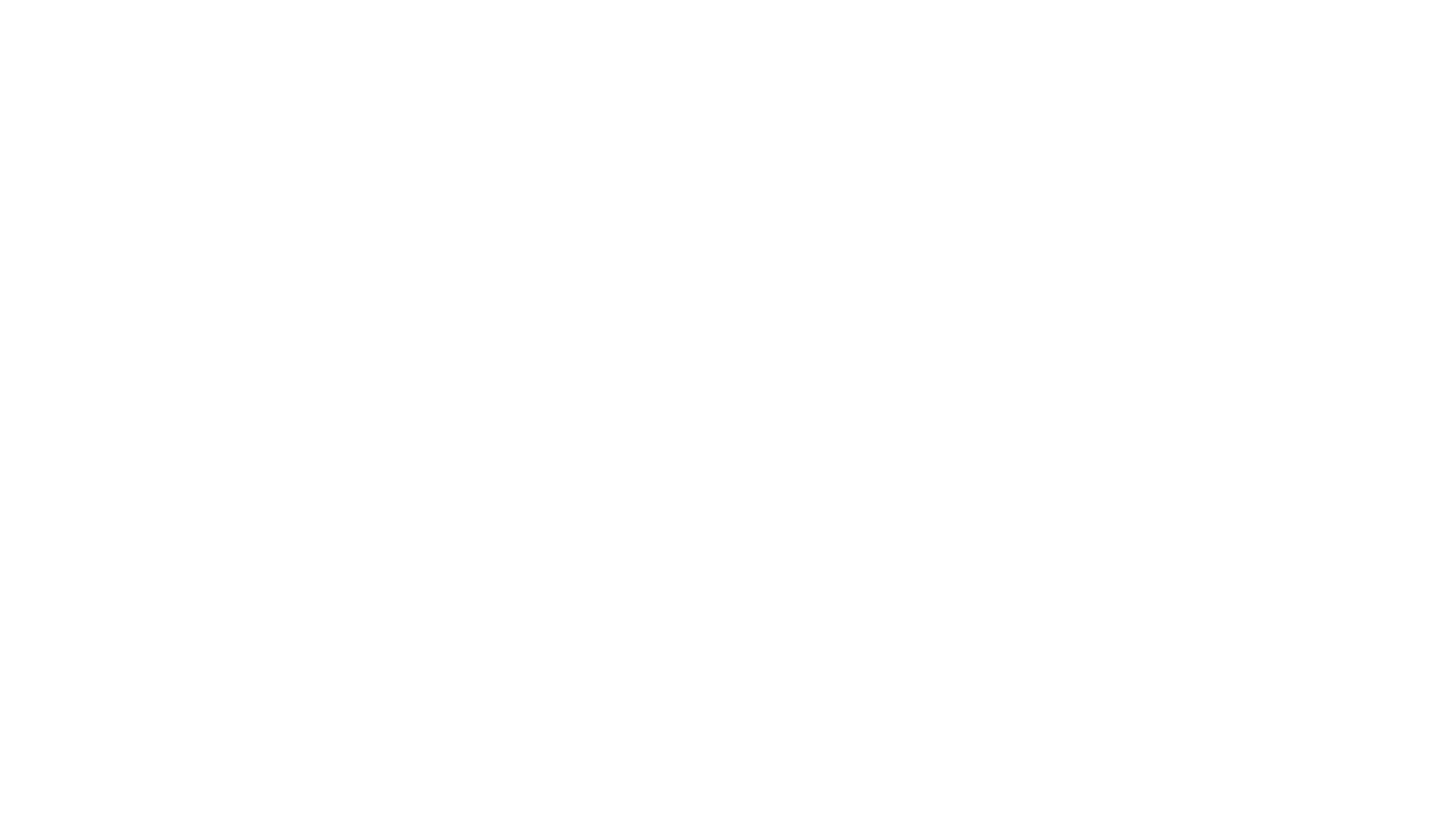
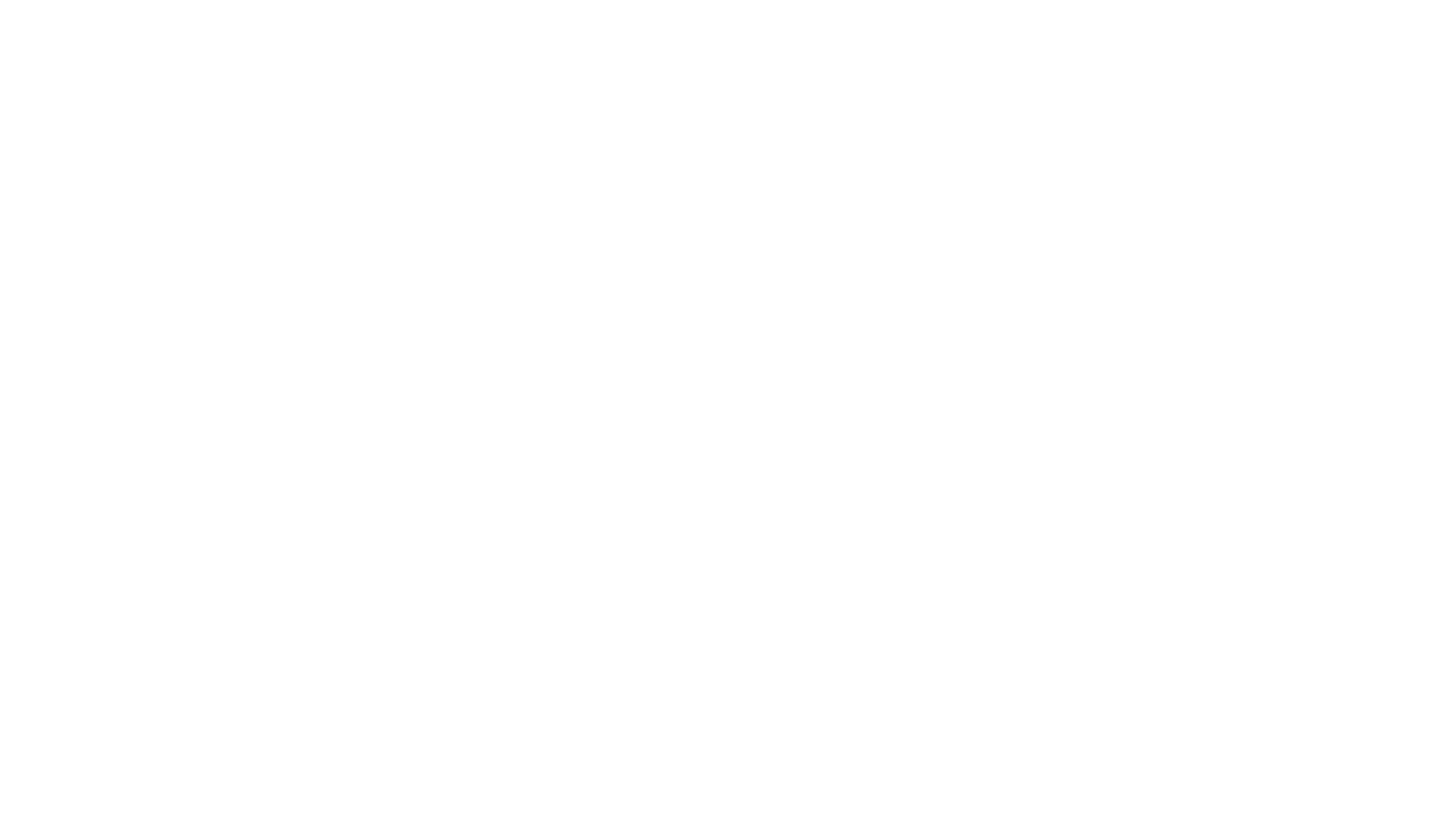
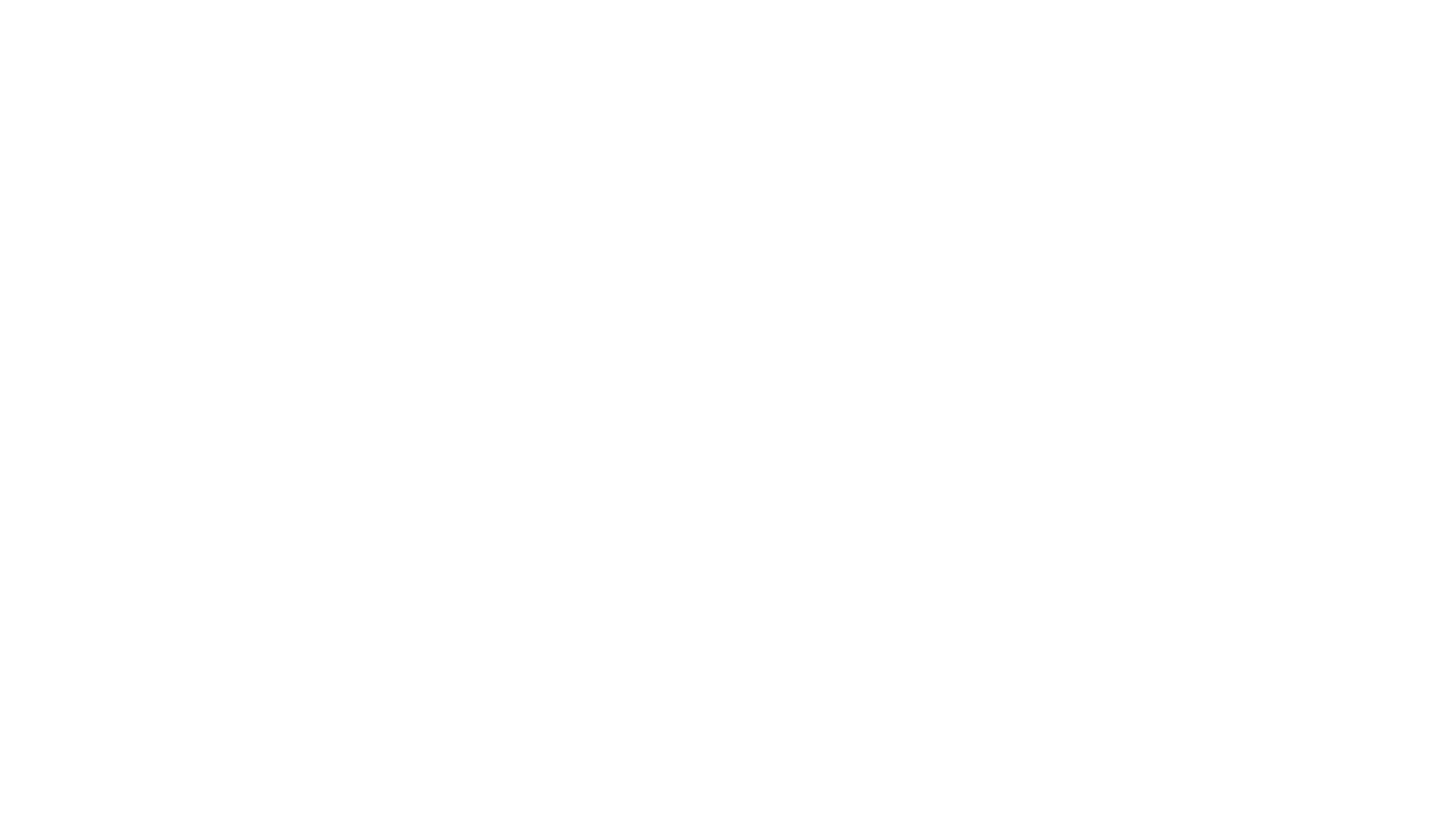


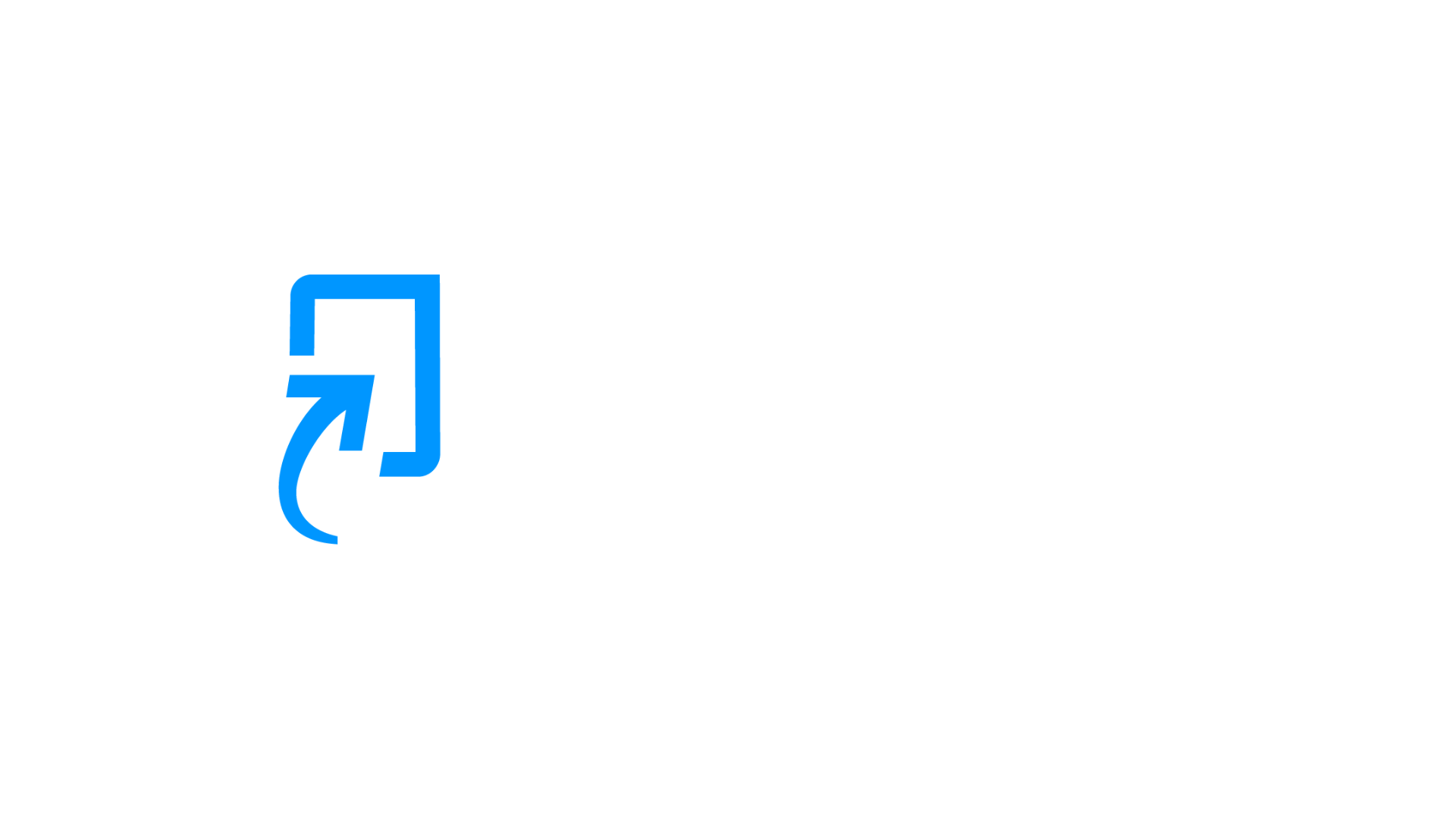
Abbiamo raccolto contenuti utili e aggiornati per aiutarti ad affrontare con più consapevolezza il percorso universitario e i primi passi nel mondo del lavoro.